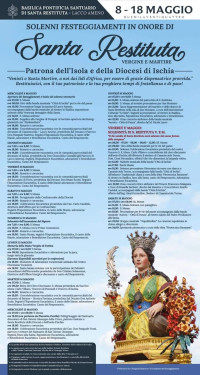di Giuseppe Mazzella – Il Continente
È dal 1968, quando a 19 anni iniziai a studiare economia politica come scienza sociale fondamentale, che ho cominciato ad avere idee chiare sullo sviluppo economico. Frequentavo l’unico corso universitario che seguii regolarmente presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Napoli, con il prof. Giuseppe Palomba, nell’anno accademico 1968/69.
L’ho già scritto e lo ripeterò ancora: quel corso sull’"espansione capitalistica" – un testo oggi introvabile – mi fece comprendere, in piena epoca di contestazione giovanile (quando giganteggiava il libro di Herbert Marcuse "L’uomo a una dimensione"), che bisognava stare con i piedi per terra. La contestazione aveva senso, ma serviva una visione riformista e concreta. Scoprii che bisognava cercare nel capitalismo un volto umano, perché la storia europea era ricchissima di passi avanti e indietro: due o tre secoli non si cancellano facilmente, se è vero – com’è vero – che la storia la fanno gli uomini nel contesto in cui vivono.
Quello studio mi portò a una visione riformista, non rivoluzionaria dello sviluppo. Non aderii al Movimento Studentesco perché lo ritenevo velleitario. Mi collocavo idealmente in una “sinistra di destra” che mirava a costruire una sinistra di governo, ma dentro il capitalismo, non nel comunismo come lo si concepiva a Praga o a Berlino.
La concezione dello sviluppo economico era – ed è – un punto centrale per qualsiasi "alternativa democratica". In quegli anni volevamo mettere la Democrazia Cristiana all’opposizione, ma io volevo farlo da laico, non da seguace di Lenin. Questa distinzione mi avvicinava più ai liberali che ai comunisti. Così nacque anche la mia amicizia con Sergio Piscitelli, coetaneo e compagno di studi, convinto sostenitore del liberalismo.
Dallo studio dell'espansione capitalistica – che analizzava circa tre secoli di storia economica – capii che lo sviluppo economico è legato alla remunerazione del denaro. Ammiravo l’espansione dell’impero britannico, ma capivo anche che, se il denaro non veniva adeguatamente remunerato, l’investitore privato non investiva. Questo divenne per me un assioma da applicare anche allo sviluppo locale: se non c’è l’affare, non c’è investimento.
Così iniziai a leggere con chiarezza il miracoloso sviluppo turistico ed economico dell’isola d’Ischia, ma compresi anche il ruolo fondamentale dell’intervento statale: infrastrutture, incentivi, sostegno alle imprese. Se un investimento non produce reddito, non si fa.
Il caso emblematico è quello del complesso del Pio Monte della Misericordia di Casamicciola: 52 anni perduti. Solo oggi, dopo decenni di battaglie, si è arrivati a una soluzione pubblica con ritorni a lunghissimo termine.
L’Ossessione
Se questo era l’assioma – una verità evidente, condivisa nell’ordinamento della Repubblica – allora l’intervento pubblico doveva entrare in gioco solo quando il capitale privato non aveva interesse a investire per via di tempi lunghi di remunerazione.
In altre parole: quando lo sviluppo non è spontaneo, lo Stato deve intervenire per riequilibrare le disuguaglianze economiche e sociali. Questo principio fu alla base della nascita della Cassa per il Mezzogiorno nel 1950. Non a caso Luigi Einaudi, liberale e primo Capo dello Stato repubblicano, ne sostenne la missione.
Negli anni ’70, guardando all’isola d’Ischia – la mia terra, la mia ossessione – capii che Casamicciola era diventata un’area in perdita: un termalismo obsoleto, un tessuto economico debole. Da lì, l’ossessione: serviva intervento pubblico per rilanciare lo sviluppo, utilizzando le leggi esistenti e cogliendo ogni opportunità.
Nel 1975 entrai in Consiglio Comunale, rieletto nel 1981, prima in minoranza poi in maggioranza. Nel 1982, con la giunta di sinistra, promossi il convegno "Termalismo e turismo in Campania: il ruolo degli enti locali, della Regione e dell’imprenditoria pubblica e privata", tenutosi il 17 e 18 aprile presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Enrico Mattei.
Fu presente Domenico Tamburini, vicepresidente dell’INSUD – la finanziaria della Casmez per interventi diretti nel turismo del Sud – che si disse disponibile a investire nel complesso del Pio Monte della Misericordia per farne una "cittadella termale", un vero villaggio turistico. Le leggi c’erano. I fondi anche. Non se ne fece nulla. Prima grande occasione perduta. Era il 1982, 43 anni fa.
Ma l’ossessione continuava.
Nel 1997, 28 anni fa, si presentò l’occasione dei "patti territoriali" e della programmazione negoziata. Il 20 dicembre organizzai un nuovo convegno presso "Il Capricho de Calise", presentando la società di sviluppo "Therme di Casamicciola", da trasformare in società di trasformazione urbana, come previsto dalla Legge Bassanini. Dovevano partecipare al capitale le banche del territorio: Banco di Napoli, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Torre del Greco, Banco di Roma. E il Comune di Casamicciola. Non se ne fece nulla.
Nel 2014, undici anni fa, un altro tentativo: il workshop "Per Casamicciola: una terza rinascita", il 29 novembre. Questa volta si presentava un progetto di fattibilità di trasformazione urbana, sostenuto dall’art. 120 del Testo Unico degli Enti Locali del 2000, che recepiva la Legge Bassanini. C’erano i fondi europei del programma 2014-2020. Altra occasione mancata.
L’ossessione per il rilancio di Casamicciola continua.
La campagna di stampa continua.
Per ora, il primo racconto finisce qui.